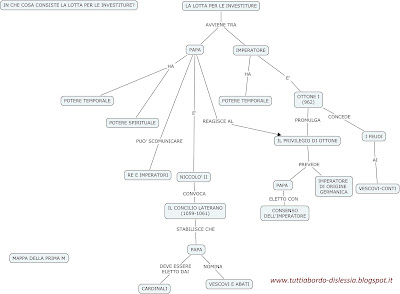di Giulia Ogliaoro
Comunità è la parola d’ordine per orientarsi nella poetica di Virgilio Sieni, danzatore e coreografo fiorentino, tre volte vincitore del Premio Ubu e già direttore della Biennale Danza. Classe 1958, una laurea in architettura e una curiosità tenace che spazia dall’arte visiva alla biologia, da più di trent’anni Sieni usa la danza per interrogarsi sul nostro essere nel mondo, per misurare, letteralmente, i rapporti e le distanze fra individui.
Che cosa significa avere un corpo, che cosa significa accostarsi e vivere in prossimità degli altri: sono queste le domande sottese agli spettacoli degli anni Novanta, incentrati sulla fiaba e sulla tragedia, ed esplorate via via con lavori sempre più aperti e partecipati. È il caso, per esempio, dei cammini popolari, proposti da Sieni in varie città del mondo, esperienze a cui partecipano persone comuni di ogni età e provenienza. In tempi di pandemia, dissesto ecologico, cultura risospinta ai margini e dibattiti culturali spesso autoreferenziali, il teatro di Sieni ci parla di cooperazione, empatia, alleanze, di nuovi modi di abitare il corpo, e il mondo.
Partirei da un dato all’apparenza semplice, ma che mi sembra abbia inciso molto sulle nostre vite, e cioè l’impossibilità di toccarsi. Questo tempo richiede nuovi modi di incontrarsi, di entrare in contatto. Cosa può insegnarci la danza?
Rinunciare a toccarsi non è cosa da poco: il tatto è il gesto più umano, più naturale, quello che ci rivela al mondo. Ciò che ci ha formato come esseri umani è stato proprio lo sviluppo della tattilità, l’evolversi dei polpastrelli, rendere la mano una macchina emozionale, spirituale, fisiologica, necessaria all’uomo per salvare la specie. Oggi ci viene chiesto di rinunciare a un’abitudine millenaria, di elaborare nuovi modi di stare vicini. Ma toccarsi non implica per forza il tatto, enella danza questo è molto evidente: bisogna immaginare lo spazio che ci separa dall’altro come uno spazio vivo, mobile; bisogna immaginare il corpo non come un’entità finita, chiusa nel perimetro della pelle, ma qualcosa di più ampio, aperto, un territorio che si lascia attraversare.
Nella danza, ma anche nelle discipline orientali, si parla di spazio tattile: di uno spazio, cioè, che non si esaurisce in ciò che posso immediatamente toccare. Si tratta di attivare un’attenzione piena, di raggiungere l’altro attraverso il suo intorno, la sua aura.
In questi giorni si discute molto della proposta del ministro Franceschini di creare una “Netflix della cultura”, una piattaforma streaming per la visione di spettacoli, concerti e altri contenuti culturali. Lei crede che quella del virtuale sia una strada percorribile, che, se adeguatamente sfruttata, aprirebbe al teatro possibilità finora inesplorate? Oppure, proprio perché ora fatichiamo a incontrarci, dovremmo difendere la relazione in presenza, e immaginare nuovi modi di stare insieme?
La dimensione del virtuale non può e non deve sostituirsi allo spettacolo vivente. In gioco non c’è solo la relazione con l’altro, l’incontro vis-à-vis, ma il percepire che siamo compresi in uno spazio. Il teatro permette questa attenzione allargata, questa apertura, ci fa capire che non c’è solo l’umano, che siamo generati da un ambiente. È qualcosa che necessariamente si perde quando si migra nel virtuale.
Inoltre credo che limitarsi a riprendere gli spettacoli, o trasmettere di continuo dei lavori rappresentati nei teatri, come fanno alcune reti televisive, sia una dimensione troppo rozza, brutale, che può persino portare a un allontanamento dell’arte dal vivo. Quella del virtuale è una faccenda complessa, che richiede intelligenza, piattaforme mirate, di elaborare prodotti ad hoc insomma. È un momento di grande sperimentazione, ma proprio per questo io lavorerei sodo per tornare in presenza, per trovare, come suggerivi, soluzioni inedite, legate a un concetto di tattilità più ampio rispetto a quanto immaginato finora.
Anche in un momento in cui i teatri godevano – o sembravano godere – di ottima salute, lei ha spesso portato la danza in luoghi altri: nei boschi, nelle piazze, nei musei, nelle periferie delle città. Da dove nasce questa esigenza?
Nasce da una stanchezza per il teatro così come lo conosciamo oggi: puro passatempo, circoscritto all’ultimo momento della giornata, a quell’oretta o oretta e mezza dopo il turno lavorativo. Tornare a riflettere sui luoghi del teatro vuol dire innanzitutto provare a sovvertire questa logica, riscoprire una geografia emozionale della città. Cosa significa questo? Non certo, come troppo spesso accade, individuare la bella facciata di una chiesa e farci uno spettacolo davanti. Non certo limitarsi a trasportare una rassegna di teatro fuori, all’aperto, solo perché è estate e siamo in maniche corte.
Riconnettere teatro e città significa mobilitare le intelligenze, fare un discorso sociologico, antropologico, filosofico anche, legato alla città, e al vivente. A me piace parlare di tessitura, perché sottintende un lavoro molto preciso, quello di ricucire il tessuto urbano là dove c’è bisogno. Il teatro deve stare in questo strappo, in questa ferita.
Un’altra cosa che mi colpisce del suo lavoro è l’attenzione verso corpi differenti, ai margini della danza e dello spazio sociale. Tra i numerosi esempi che potrei fare, il più commovente è forse Tre Agorà, realizzato nel 2013 a Marsiglia con la collaborazione di Alessandro Leogrande: per tre giorni la città è stata occupata da anziani, bambini, profughi, non vedenti, dai terremotati di Carpi e dalle donne tarantine che vivono nei quartieri avvelenati dall’Ilva. Una comunità di sommersi e salvati, riuniti in scena per immaginare un futuro diverso, più umano. Qual è stata la genesi di quel lavoro?
Tre Agorà riuniva tante azioni e diversi gruppi di cittadini, era il punto di arrivo di un progetto portato avanti per più di quattro anni tra Italia, Francia e Spagna. L’idea era quella di creare un atlante del Mediterraneo, un archivio di gesti che accostati insieme andassero a formare una memoria comune. Prima di Marsiglia ero stato nei luoghi d’origine di ognuna delle persone in scena – mi ricordo, per esempio, le donne di Pezze di Greco che filavano i pomodori, gli artigiani di Carpi… Avevamo lavorato in un processo di sottrazione, di archeologia del corpo: non aggiungendo gesti e movimenti per creare coreografie, ma togliendo dai gesti, dalle pratiche che appartenevano a quei territori e a quelle persone tutto ciò che fosse superfluo, in modo che in scena risplendessero come se fatti per la prima volta.
La collaborazione con Alessandro, in tutto questo, è stata fondamentale. Da scrittore, e da amico, seguì ogni fase del lavoro, e sulla base dei nostri dialoghi, delle conversazioni infinite sui luoghi delle prove scrisse poi i testi di Trois Agoras Marseille, pubblicato da Maschietto Editore. Lui aveva questa capacità, sapeva cosa salvare: in un mondo in cui tutto sembra urgente e poi non lo è, lui capiva su cosa valesse davvero la pena soffermarsi. E poi per l’arte nutriva una passione autentica – basta pensare a come finisce La Frontiera, con il suo viaggio a San Luigi dei francesi, citando il Martirio di San Matteo…

L’interesse per l’arte figurativa, e in particolare per la pittura rinascimentale, è un’altra costante del suo lavoro. Come se la danza – il corpo – fosse il punto di incontro di due dimensioni, quella estetica e quella politica.
Si tratta di due dimensioni che da sempre si compenetrano, si alimentano a vicenda. Io non ero un bambino molto espansivo, amavo rifugiarmi nel disegno, e quella fascinazione per l’immagine poi è rimasta, si è sedimentata nel tempo. In Solo Goldbergh Variations, uno spettacolo che propongo ormai da molti anni, attraverso in scena una cinquantina opere d’arte tra il 1300 e il 1600 italiano, cerco proprio di tradurle con il corpo, assimilando quelle pose, quei gesti, quelle pieghe del capo…Non si tratta di imitare, ma di affidarsi alla potenza della figura. Anche quando conduco dei laboratori mi piace spesso partire dalle immagini, perché più di tutto nella pittura c’è questo, c’è il gesto nella sua misura esatta, liberato dall’abitudine e dallo sforzo produttivo. E qui entra in gioco anche la dimensione politica, nella ricerca di un corpo aperto, disponibile, inoperoso.
Qualcosa di simile accade anche in Tattilità delle chiome, presentato a Matera all’interno del festival So far so close: i cittadini-danzatori danno vita a dei movimenti cercando di incorporare, di tradurre fisicamente i volumi, le forme, l’ombreggiatura di una pianta (di un gelso, in quel caso). Un lavoro che espande ancora di più il desiderio di comunità, rivolgendo l’attenzione al di fuori dell’umano…
È esattamente così. Tattilità delle chiome nasce proprio dal desiderio di ricostruire l’empatia verso l’ambiente, verso le altre specie. Ci poniamo – finalmente – il problema di come abitiamo il mondo ma al tempo stesso dovremmo lasciarci abitare, aprire nel corpo nuove possibilità articolari. Un montanaro o un contadino probabilmente sapranno dire che cosa significa vivere nelle tracce della natura, ma per un cittadino metropolitano è più difficile ricucire questa sensibilità, e non conosco altro modo di farlo se non partendo dal corpo, dalla possibilità di sperimentare, attraverso la danza, che non siamo esseri finiti, chiusi: viviamo di dipendenza, di scambio di segnali con l’esterno.
Ha esordito poco più che ventenne con la Compagnia Parco Butterfly, poi divenuta Virgilio Sieni: se guarda al suo percorso, che cosa crede sia cambiato maggiormente rispetto ai primi spettacoli?
C’è da dire che io sono un po’ smemorato… Be’, il corpo mi sembra rimasto pressoché costante come centro di interesse. Intendo più che altro l’archeologia del corpo, questa idea della danza come scavo, come recupero di un gesto più antico. Se devo dire cosa è cambiato, forse è molto semplice: sono invecchiato. E ho capito che quello sul corpo è uno studio inesauribile. Ora mi affascina proprio questo, come il corpo invecchiando produce sempre delle novità. Tutte gli spazi muscolari, molecolari che si aprono dentro di noi, e come modificano il nostro stare al mondo… Tutto quello che ricordiamo, che resta impresso nei movimenti, e quello che dimentichiamo.
_________________
Giulia Oglialoro è nata nel 1992. Dopo la laurea in Arti Visive all’Università di Bologna ha lavorato per la Biennale di Venezia e per l’agenzia fotografica ReduxPictures di New York. Scrive per Artribune, Arte, Q Code Magazine e nel 2020 ha collaborato alla drammaturgia dello spettacolo Fase Nove // Assolo Urbano, prodotto da Zona K con il collettivo berlinese Rimini Protokoll.
The post Cerco l’infinito dei corpi. Conversazione con Virgilio Sieni first appeared on minima&moralia.












.jpg)